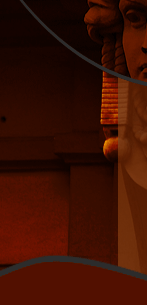


|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
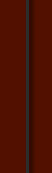 |
(Roma, Università La Sapienza, 1982) Il gruppo marmoreo di Mitra che uccide il toro , rinvenuto nel luglio 1938 nelle cosiddette Terme del Mitra ad Ostia, ed oggi collocato nella II sala del Museo Ostiense ,merita un approfondimento per quel che riguarda le sue origini e la sua collocazione stilistica, essendo nella sua struttura , totalmente differente da tutte le altre raffigurazioni mitriache del tempo. Il gruppo, in marmo greco con venature verdastre e molte impurità di calcite e quarzo ha delle dimensioni notevoli:m.1,70 di altezza; m.1,93 di lunghezza; m.0,50 di larghezza sulla fronte; m.0,72 di larghezza sul retro. Lo stato di conservazione è il seguente: mancano le orecchie del toro e i pezzi della coda, la parte estrema delle zampe posteriori, il fodero del pugnale, il berretto frigio ( di cui rimane il foro del perno) e la la lama del coltello. Vi è una rottura sul bordo del chitonisco del dio, nella punta del naso e su due dita della mano destra.
Il gruppo raffigura il dio Mitra nell’attimo prima dell’uccisione del toro. Il dio, premendo con il ginocchio sinistro il dorso del toro e arretrando la gamba destra con il piede puntato a terra, tiene ben fermo l’animale e con la mano sinistra ne afferra saldamente il muso portandolo all’indietro. Con la mano destra levata sta per immergere il pugnale nella spalla del toro; la testa è rivolta verso l’alto.
Mitra indossa un semplice chitonisco di stoffa pesante, corto sopra ai ginocchi, che lascia scoperta la spalla destra, con due piccoli spacchi laterali sull’orlo inferiore e uno sulla spalla. In vita ha una cinturina di cuoio che si restringe sul davanti in due cordoncini annodati. A tracolla porta un balteo che sosteneva sul fianco sinistro il fodero del pugnale. La parte posteriore della testa è rozzamente scalpellata ed era completata dal berretto frigio, oggi mancante. Sul petto del toro è inserita la firma dell’autore, disposta su tre righe: K R I T O N A T E N A I O S E P O I E I L’artista greco che ha eseguito il gruppo, Kriton, è forse identificabile con M. Umbilius Criton, che nel mitreo ostiense della Planta Pedis (1) presso il Serapeo dedicò un labrum marmoreo a Mitra. Prenome e gentilizio ci riportano al senatore M. Umbilius Maximus, noto da iscrizioni ostiensi, che forse fece ottenere a Kriton la cittadinanza romana, e lo stesso Kriton, proprio per questo, ne assunse i nomi, aggiungendovi come cognome il suo originario nome greco. Il gruppo fu ritrovato al suo posto originario, in fondo al mitreo. L’edificio non ha una nicchia, e la parete di fondo, liscia, doveva avere una decorazione dipinta, in modo da servire come sfondo cromatico per la statua. Il gruppo marmoreo è stato rinvenuto sulla sua base in muratura, alta 30 cm., e disposta in diagonale. Il lucernario sopra il gruppo faceva filtrare la luce (2), che cadeva sul gruppo stesso, con effetto suggestivo e mistico. Il Mitraismo (3) religione che nacque in Persia, fu trasportato a Roma dai soldati di Pompeo nel 67 a.c. L’apogeo del culto di Mitra fu verso la metà del III sec. Da quell’epoca avvenne una rapida decadenza a causa delle invasioni barbariche e dei progressi del cristianesimo, giacchè nella seconda metà del del IV sec. Inizio’ un periodo di furiosa persecuzione contro Mitra. Il Mitraismo è abbondantemente documentato a Roma e ad Ostia da edifici di culto, il quale, anche all’epoca della sua massima diffusione rimase sempre di carattere privato; alcuni mitrei rinvenuti sono infatti in collegamento con edifici privati, per lo più abitazioni di ricchi personaggi del II e del III sec.
Solitamente (4) le raffigurazioni più consuete di Mitra sono in rilievo e rappresentano il dio con il costume orientale, il manto svolazzante trapunto dalle sette stelle e dalla mezzaluna. Mitra tiene ben saldo il toro ponendo sopra di esso il ginocchio e gli inserisce il pugnale nel fianco.
Il sangue che scaturisce dalle ferite, si converte spesso in tre spighe di grano: un cane balza a lambire questo sangue, un serpente striscia verso la ferita; uno scorpione afferra i testicoli della vittima. Ai due lati del toro figurano generalmente due portatori di fiaccole, Cautes e Cautopates. Questi due dadofori formano con il dio stesso una trinità e ne portano anche il costume.
L’unico caso a noi noto di rappresentazione mitriaca a tutto tondo è rappresentato dal gruppo di San Clemente, in cui il dio è raffigurato anche in un gruppo statuario collocato in una nicchia come Sol Invictus, quasi una personificazione di Apollo – Helios. Anche il gruppo di Kriton è una grande e maestosa scultura a tutto tondo, dove il giovane dio scalzo, vestito solo della piccola exomis, trattiene con una mano il muso del toro e con l’altra brandisce il pugnale di bronzo (la cui lama è oggi perduta) preludendo a quella che sarà l’uccisione del toro. E’ la rappresentazione inconsueta dell’attimo prima del supremo sacrificio, pieno di mistica attesa. Quindi non immergendo il coltello, non può sprizzare il sangue a cui il cane ed il serpente potessero abbeverarsi. Si noti, anzi che lo scultore ha raffigurato il corpo del toro completamente schiacciato a terra ( a differenza dello schema comune) e aderente alla base, in uno spazio in cui il cane ed il serpente non troverebbero posto. La rappresentazione del dio nel
momento precedente all’'uccisione del toro, si riscontra in un Il Becatti (6) affrontò il problema della collocazione stilistica del gruppo, in un primo tempo, evidenziando delle somiglianze tra la testa del Mitra ostiense e quella di Alessandro- Helios (notoci dalla copia del Capitolino), dall'’espressione patetica, che lo avrebbe ispirato. Infatti si unirebbero due opere, testimonianze della trasformazione del tipo Alessandro – Helios in Mitra , che si potrebbe accostare al nostro gruppo: una testa del Barracco ( già considerato dallo Schreiber Alessandro – Helios, ma da ritenere Mitra per il berretto frigio) e la testa del Mitra ostiense degli Animali, oggi al Museo Gregoriano Profano. Ambedue queste teste mostrano un modellato di stile tardo-ellenistico di ambiente asiatico, forse pergameneo. Ma, a differenza di queste, la testa di Kriton si distingue per un modellato più duro e per un carattere più spirituale che la riallaccerebbe a sculture attiche tardo- ellenistiche, quali quelle di Damophon da Messene ed Euboulides.
Il Becatti ha ripreso successivamente l’argomento analizzando un gruppo marmoreo, raffigurante un “Gladiatore che uccide il leone” della Collezione Giustiniani nel Parco di Bassano di Sutri, che rappresenta l'’unico confronto preciso con il gruppo ostiense. Sebbene il gruppo di Sutri abbia subìto molti restauri cinquecenteschi, tuttavia quel che resta di ’antico delle figure, cioè il torso, corrisponde esattamente alla statua di Kriton. Infatti quello che si intravede attraverso la forte patina sembra indicare delle precise corrispondenze con il Mitra ostiense, nel ductus delle pieghe del panneggio, nella struttura generale del nudo, anche se con un modellato più rozzo. I caratteri ellenistici riscontrabili nelle due opere potrebbero far pensare ad una creazione di ambiente microasiatico, ma finora non si hanno elementi che possano confermare una simile tipologia del Mitra sia in Asia minore sia in Grecia, sia nella penisola balcanica come del resto in ogni altro centro dove rimangono delle testimonianze della regione mitriaca. La datazione del gruppo ostiense, piuttosto alta (età adrianea o immediatamente successiva), quando il culto mitriaco non si era molto diffuso è forse all’origine delle numerose differenze rispetto agli schemi consueti. Il problema stilistico, pur con il raffronto della copia Giustiniani, non si è più risolto e rimane aperto: forse Kriton, neoattico, ideatore di questo Mitra ellenistico, eseguì il gruppo ostiense a Roma ( qui esisteva una fiorente scuola di artisti neoattici), dove sarebbe stato copiato e l’originale, già deteriorato sarebbe finito nel mitreo ostiense, o forse il modello di Kriton e della copia Giustiniani è da ricercare altrove, in un comune archetipo. ***
1) Sul mitreo ostiense della Planta Pedis l’iscrizione di M. Umbilius Maximus è nel CIL. XIV 251 2) G. Becatti, Scavi di Ostia, II, Roma, 1954pagg, I Mitrei, Poligrafico di Stato Calza- Nash, Ostia, Sansoni, 1959, pagg Pavolini, Guida di Ostia, Laterza
3) Sul culto mitriaco: R. Turcan, Salut mitriaque et soteriologie neoplatonicienne, in Atti del colloquio su la soteriologia dei culti orientali nell’impero romano, EPRO, Leiden, 1982, pagg.173-185 I. Chirassi Colombo, Il sacrificio dell’essere divino, in Atti del coll.su la soter.dei culti orientali nell’imp.rom., EPRO, Leiden, 1982, pagg.314-317 B. Lincoln, Mithra(s) as sun and savior, in Atti del coll.su la soter.dei culti orientali dell’imp. Rom., EPRO, Leiden 1982, pagg.505-517 Meiggs, Roman Ostia, Oxford, 1960, pag.372 ss. Bianchi (ed), Misteria Mithrae, (EPRO 80), Leiden 1979
4) Per le caratteristiche fondamentali dell’iconografia del dio si veda ad es. un’ara marmorea, nel Mitro di San Clemente ( della fine del II sec.), raffigurante sulle quattro facce dei rilievi il dio che immola il toro ( Mitra in vesti persiane e berretto frigio introduce il coltello nella spalla del toro), i due lampadofori e un enorme serpente. Si nota così come vengono mantenuti molti elementi di base della rappresentazione mitriaca: il serpente, i lampadofori, l’atteggiamento e l’abbigliamento del dio. Ciò è evidente anche nel mitreo di S. Prisca, ( di età severiana) che, seppur con delle diversità ( di fronte al toro giace il dio velato, Caelus – Saturnus) è perfettamente riconoscibile nell’iconografia mitriaca. Vedi, a questo proposito : Vermaseren Van Essen, The excavations in the mithreum of the church of S. Prisca in Rome, Leiden, E . J. Brill,1965.
5) Questo tipo di Nike è documentato anche in monumenti romani, come nella Victoria sul Palatino, o nei frammenti di fregio co Vittorie sacrificanti un toro (INV: N: 225,236,239,72291). Sul prototipo di Nike della balaustra del tempietto di Athena- Nike nell’acropoli, concorda anche il Borbein (in Die Stiertopende Nike, munchen, 1964, pag.89) e il Vermaseren in Mithras in der Romerzeite, in Atti del colloquio internazionale su la soteriologia dei culti orientali nell’Impero Romano, Leiden, 1979, pagg.96-113. Fu, comunque, per primo Cumont a ricercare l’origine di Mitra nella Nike tauroctona, in Textes, I, pag 81 ss e 213-219. 6) G. Becatti “ Scavi di Ostia “, II, 1954, Poligrafico dello Stato. 7) G. Becatti, Attikà, Saggio sulla scultura attica dell’ellenismo, in Rivista Istituto Archeologico Storia dell’Arte VII, 1940, pag 14-16 e 52-55. 8) G. Becatti “ Una copia Giustiniani del Mitreo di Sutri” nel Bollettino d’Arte, 1957, pag 1-6.
|
|
|
|
||
| Site Map |
 I restauri vennero effettuati in
antico, quando fu acquistato il gruppo per ornare il mitreo. Essi si
riferiscono a un ginocchio del toro, al braccio destro del dio (lavorato a
parte e imperniato), a parti delle corna, un orecchio e a pezzi della coda del
toro. Questi due ultimi non sono stati riutilizzati nel restauro effettuato dopo il rinvenimento, perché avrebbero rischiato di rovinare la scultura. Questi pezzi
restaurati anticamente sono di marmo grigiastro, simile a quello della base.
I restauri vennero effettuati in
antico, quando fu acquistato il gruppo per ornare il mitreo. Essi si
riferiscono a un ginocchio del toro, al braccio destro del dio (lavorato a
parte e imperniato), a parti delle corna, un orecchio e a pezzi della coda del
toro. Questi due ultimi non sono stati riutilizzati nel restauro effettuato dopo il rinvenimento, perché avrebbero rischiato di rovinare la scultura. Questi pezzi
restaurati anticamente sono di marmo grigiastro, simile a quello della base. Al momento della scoperta
mancavano la testa del Mitra e le sue braccia, e la testa del toro, che furono
rinvenute nello scavo di una fogna che corre lungo la parete ovest del mitreo.
Oltre ad esse si rinvennero altri pezzi del gruppo che erano già stati
restaurati anticamente: un orecchio del toro, parti delle corna e della coda,
in ginocchio. Dato che nel grande salone sovrastante absidato delle terme si
sono trovati due pilastrini con i monogrammi cristiani scolpiti, testimonianti
il luogo del culto, è probabile che, quando i cristiani occuparono le terme,
volutamente abbiano distrutto e saccheggiato il mitreo sottostante,decapitati
il toro e Mitra, rompendo le braccia e altri pezzi più facilmente staccabili, e
abbiano gettato tutto volontariamente nella fogna vicina, lasciando il pesante
gruppo acefalo e mutilo.
Al momento della scoperta
mancavano la testa del Mitra e le sue braccia, e la testa del toro, che furono
rinvenute nello scavo di una fogna che corre lungo la parete ovest del mitreo.
Oltre ad esse si rinvennero altri pezzi del gruppo che erano già stati
restaurati anticamente: un orecchio del toro, parti delle corna e della coda,
in ginocchio. Dato che nel grande salone sovrastante absidato delle terme si
sono trovati due pilastrini con i monogrammi cristiani scolpiti, testimonianti
il luogo del culto, è probabile che, quando i cristiani occuparono le terme,
volutamente abbiano distrutto e saccheggiato il mitreo sottostante,decapitati
il toro e Mitra, rompendo le braccia e altri pezzi più facilmente staccabili, e
abbiano gettato tutto volontariamente nella fogna vicina, lasciando il pesante
gruppo acefalo e mutilo. Finora ad Ostia sono stati
identificati diciotto mitrei, segno che il Mitraismo trovò nella popolazione
ostiense un terreno particolarmente fertile favorevole . Mitra è il dio
persiano del Sole, salvatore degli uomini, che dona la forza terrestre
simbolizzata dal toro. Il culto, riservato alle confraternite private, aveva
luogo quasi sempre in santuari sotterranee, specie di cripte semibuie, alla
presenza di pochi fedeli , ai quali era assicurata l’immortalità dell’anima.
Finora ad Ostia sono stati
identificati diciotto mitrei, segno che il Mitraismo trovò nella popolazione
ostiense un terreno particolarmente fertile favorevole . Mitra è il dio
persiano del Sole, salvatore degli uomini, che dona la forza terrestre
simbolizzata dal toro. Il culto, riservato alle confraternite private, aveva
luogo quasi sempre in santuari sotterranee, specie di cripte semibuie, alla
presenza di pochi fedeli , ai quali era assicurata l’immortalità dell’anima.  disco bronzeo
oggi all'Ashmolean Museum di Oxford, in cui Mitra indossati come sempre in
berretto frigio e le vesti orientali, non ha ancora immerso il coltello nel
collo del toro, analogamente al gruppo di Kriton. Questo stesso schema ripete
quello della Nike tauroctona (5) già fissato nell’arte greca alla fine del V
sec. E di cui una delle immagini più note è la figura sulla balaustra di
Athena-Nike sull’'Acropoli di Atene. La tradizione della Nike bouthytousa si
ritrova in Grecia in vasi, monete, gemme, terracotte, che presentano notevoli
affinità con il gruppo di Kriton; affinità già sottolineate dal Cumont che fa
risalire il gruppo intorno al II secolo.
disco bronzeo
oggi all'Ashmolean Museum di Oxford, in cui Mitra indossati come sempre in
berretto frigio e le vesti orientali, non ha ancora immerso il coltello nel
collo del toro, analogamente al gruppo di Kriton. Questo stesso schema ripete
quello della Nike tauroctona (5) già fissato nell’arte greca alla fine del V
sec. E di cui una delle immagini più note è la figura sulla balaustra di
Athena-Nike sull’'Acropoli di Atene. La tradizione della Nike bouthytousa si
ritrova in Grecia in vasi, monete, gemme, terracotte, che presentano notevoli
affinità con il gruppo di Kriton; affinità già sottolineate dal Cumont che fa
risalire il gruppo intorno al II secolo.